|
|
 |
 |

Percorsi |
 |
 |
| |
Sezione a cura di Antonio Spadaro e Fulvio Panzeri
Alberto Garlini
Tutto il mondo ha voglia di ballare
Mondadori, pag.344, euro 17,50
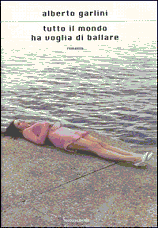
Da un paio d'anni la moda del "vintage" ha fatto ritornare in voga gli anni Ottanta, con le sue canzoni, con quell'illusione di un tempo vissuto come una festa continua, forse per nascondere un vuoto che covava dentro. Anche il romanzo ha iniziato una riflessione in questo senso e dopo la bella prova narrativa di Leopoldo Carra, L'estate muore (Ponte alle grazie), ecco che arriva ora Alberto Garlini, uno dei migliori scrittori di quella generazione che è stata troppo in fretta etichettata come pulp. Garlini è un esempio di sottrazione consapevole a quest'etichetta, uno scrittore vero, che affonda la sua scrittura nel tema di una sacralità perduta tra le pieghe di un mondo giunto al capolinea. Casualmente anche il suo nuovo romanzo Tutto il mondo ha voglia di ballare prende le mosse da Parma, come nel romanzo di Carra e inscena storie che si intrecciano in un lungo viaggio, che ha come cartina di tornasole, il libro che maggiormente rappresenta gli anni Ottanta, "presi in diretta", Un weekend postmoderno di Pier Vittorio Tondelli, che diventa anche lui personaggio del romanzo, come era già successo per Pasolini nel precedente romanzo di Garlini Fùtbol bailado (Sironi), Non è però una biografia di Tondelli, mascherata sotto forma di romanzo, ma una accorata e intensa rivisitazione di un'esperienza letteraria attraverso episodi raccontati nella sua opera, con un'intuizione forte, quella degli anni Ottanta intesi come una "festa mobile" incontro alla morte, tema per anni taciuto, ma vera chiave di lettura per interpretare il decennio. E Tondelli, viaggia, pensa, ama, osserva, insieme ad un gruppo di ragazzi, Roberto e Riccardo, che si conoscono da bambini, durante la festa per l'uccisione del maiale e poi soprattutto l'enigmatica e tormentata e bellissima Chiara che, a causa di un incidente, perde l'uso delle gambe e aspetta un miracolo. La riuscita del libro sta nell'aver usato le storie di Tondelli e le sue intuizioni "come fossero un corpo vivente, capace di amare e di provare dolore", di entrare nel loro cuore pulsante.
Fulvio Panzeri
AUTOBAHN di Fulvio Panzeri
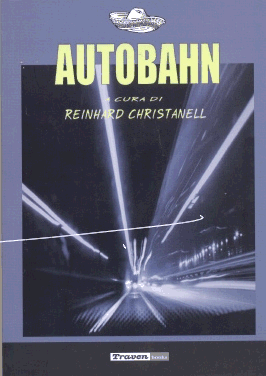
"Autobahn" è il racconto che chiude il primo libro di Pier Vittorio Tondelli, Altri libertini, scritto nel 1980. Registra i pensieri, le illusioni e i desideri di un ragazzo, seduto sul calcavia dell'autostrada del Brennero, che immagina di poter intuire, oltre il grigio della pianura, lo spazio aperto del Mare di Nord. "Autobahn" diventa così una prospettiva di viaggio, lungo una direttrice che dall'Emilia, taglia il Trentino Aldo Adige e porta verso la Germania, Berlino e l'Europa.
Autobahn (Traven Books) è diventato anche il titolo di un'antologia di racconti, curata da Reinhard Christanell, un omaggio al racconto di Tondelli, una reinterpretazione di quei luoghi illusi e desiderati, una giro lungo l'autostrada , "un luogo in cui – secondo Christanell – difficilmente si riconosce la vita, anzi nessuno se ne interessa proprio. Eppure, anche le autostrade hanno un'anima". Scoprire qual è la sua dimensione più vera, quale "popolo" la abita, come si innesta nel territorio è ciò che emerge da questi racconti. Sottolinea ancora il curatore: "Ecco allora il senso di un viaggiare/scrivere dedicato all'autostrada, ai suoi significa(n)ti, al materiale (umano e non) traghettato da un capo all'altro dell'interminabile striscia d'asfalto, nel nostro caso, i 313 chilometri dell'Autostrada del Brennero, la A22, che collegano nord e sud, gente del nord e gente del sud, culture del nord e culture del sud".
Tra gli autori troviamo nomi noti della narrativa e della poesia italiana, da Daniele Benati a Dacia Maraini, da Vivian Lamarque a Gregorio Scalise, da Dario Voltolini allo stesso Alessandro Tamburini e a Alessandro Banda. C'è però uno sguardo nuovo tra gli autori dell'antologia ed è quello dei giovani, molti scrittori
esordienti, per la gran parte residenti in Trentino Alto Adige, a Trento, a Bolzano, a Brunico, a Merano, a Riva del Garda. Ci raccontano anche la quotidianità di una regione, l'andare alle discotesche sul lago, un giro nel centro storico di Trento, "che in fondo un po' paesone lo è", come scrive Francesca Caprini, il popolo degli immigrati clandestini, le ferrovie che corrono parallele all'Autobahn, di cui racconta Paolo De Martin: "Tre treni per Egna e la Bassa Atesina. Due ore e trenta minuti per meno di cento chilometri. Nel mio lusso mi perdo nella lentezza dei treni locali e riprendo il ritmo del giusto respiro".
Soprattutto ci sono in queste storie autogrill e aree di servizio, la loro inedita prospettiva, come quella che racconta il giornalista Carlo Martinelli, una delle storie più efficaci, dando voce e calore umano ad uno dei baristi: "Potrei raccontare dei meccanici, dei camionisti, dei benzionai, di Radio Tirol che ci fa compagnia al mattino presto, quando quelli che ti chiedono il caffè o un cappuccino o la brioche hanno gli occhi gonfi e si muovono come dei sacchi di patate. C'è di tutto e io vedo e sento quel che posso".
Autori Vari, Autobahn, Traven Books, 2005 Il mio primo dopoguerra"
di Massimo Zamboni QUEL VIAGGIO A BERLINO DI MASSIMO ZAMBONI
L'ultimo racconto di Altri libertini di Tondelli è Autobahn: un ragazzo sta su un ponte dell'autostrada e, in un monologo accorato, pensa al Mare del Nord e ad una ipotetica fuga verso l'Europa, verso quella storia che molti ragazzi di quella generazione hanno inseguito scegliendo di stabilirsi a Berlino e a Londra. Altri libertini veniva pubblicato nel 1980. Ora a raccontarci che cosa è stato quel viaggio a Berlino sognato e desiderato da Tondelli è Massimo Zamboni, in un libro che potrebbe essere una raccolta di frammenti di diario, ma che diventa un vero e proprio "romanzo critico" di una generazione, come lo era stato Un weekend postmoderno di Tondelli. Infatti Il mio primo dopoguerra è uno dei libri più belli di questa annata letteraria, tale è la sincerità e la tensione personale che vibra in questo spazio di vita ricondotto all'idea di una revisione del concetto di tempo, proposto da quel grande poeta-musicista che è Zamboni. Sceglie tre città, Berlino – Beirut – Monstar, osservate in tre periodi diversi e ognuno corrispondente a un momento catartico: il 1981 a Berlino, il 2001 a Beirut e il 1998 a Monstar. A Berlino si riflette il tempo più lontano e il conto aperto con la Storia e con il Muro che sarebbe caduto. La Berlino che ci racconta è quella che ci avrebbe potuto raccontare Tondelli che a Berlino ci aveva vissuto per un certo periodo. Ed è straordinario ritrovare nelle pagine di Zamboni una voce parallela, un incrocio a distanza delle loro strade, che già si era incontrate, proprio dopo quella visita berlinese, quando i CCCP-Fedeli alla Linea, con Zamboni e Ferretti furono presentati nel primo articolo che Tondelli scriveva sull'Espresso. E l'inizio del viaggio a Berlino di Zamboni insegue quell'idea del racconto tondelliano, con quella immagine epica dei Tir e della loro fenomenologia, un mondo a parte, dove "il Tir si riscuote, e segue i pensieri dell'uomo". E aggiunge: "Viaggiare in TIR sulle autostrade tedesche di notte, ascoltando Autobahn dei Kraftwerk è un esperimento di metalinguaggio". Lo spazio dedicato a Berlino è il più consistente in questo viaggio di Zamboni. In questa prima "linea di confine" che Berlino rappresenta si formula anche il centro del libro: la cognizione di un tempo che ha a che fare con la propria storia personale, di una Storia che non scivola intorno, ma interroga. Zamboni riporta una citazione da Nel corso del tempo di Wenders: "Per la prima volta mi sento come uno che ha dietro di sé un certo tempo, e questo tempo è la mia storia". Un tempo, la cui cognizione, diventa assunzione di responsabilità, tanto che a Monstar l'intuizione berlinese si precisa e "quest'ultimo dopoguerra di Mostar è il primo dopoguerra davvero nostro. Di tutti noi, cresciuti senza guerre". E da questa constatazione il titolo del libro. C'è una grande emozione fisica e cerebrale in queste pagine che rimandano a brevi flash della storia musicale di Zamboni, ma per lo più la evitano, prediligendo e giustamente il proprio "colpo di vista", quello che porta ad un esercizio di accettazione del proprio tempo che "ci appartiene, malgrado tutto", per mettere in luce "la voglia di gioia degli sconfitti" di Beirut e Mostar, "il loro reclamo alla vita". Questa attraversata delle "città estreme" diventa un modo per mettere alla prova anche le ultime certezze degli occidentali "di sinistra", colti e equosidali. Secondo Zamboni, "nella loro crudezza non addomesticabile sono perni per l'esplosione delle nostre identità. Sembrano lì apposta per scardinarci".Fulvio Panzeri
Massimo Zamboni, Il mio primo dopoguerra, Mondadori, 2005
L'OPERA COMPLETA DI SILVIO D'ARZO
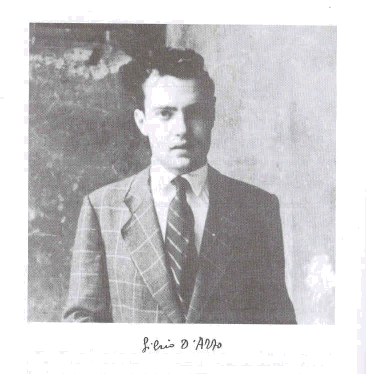
La grande lezione di un "minore" del Novecento italiano come Silvio D'Arzo è da rileggere in tutta la sua integrità. Nonostante il forte interessamento che è avvenuto negli anni Ottanta intorno alla figura di D'Arzo, autore di quel piccolo capolavoro che è il romanzo breve Casa d'altri, avvenuto da parte degli scrittori e dei critici della nuova generazione, la riproposta editoriale di questo autore, scomparso in giovane età, lasciando però un gran numero di opere in prosa, di poesie e di saggi è stata alquanto episodica e casuale. Ormai introvabile e anche datato, come curatela rispetto alle nuove acquisizioni critiche e al reperimento e allo studio delle varie redazioni delle opere, il volume edito da Vallecchi nel 1960 con il titolo Nostro Lunedì che raccoglieva l'intera produzione darziana, era necessario ripensare, a cinquant'anni dalla morte, ad un'edizione finalmente critica della sua opera. Su iniziativa di due ottimi critici e gran conoscitori del mondo di D'Arzo, quali sono Alberto Bertoni e Fabrizio Frasnedi, che firmano anche le introduzioni, a cura di tre giovani studiosi (Stefano Costanzi, Emanuela Orlandini e Alberto Sebastiani), esce un bel volume di mille pagine con "tutto" D'Arzo. L'editore è Mup di Parma che con questa iniziativa inaugura alla grande il suo progetto editoriale maggiore. Nel volume oltre ai romanzi, da quelli giovanili come Essi pensano ad altri, fino a Casa d'altri e ai racconti, troviamo le poesie, ma soprattutto i saggi con le letture critiche su Kipling, De Foe, Conrad, James, illuminanti anche come punto di riferimento per comprendere la ricerca letteraria dello scrittore reggiano. Soprattutto la sua produzione per ragazzi, che andrebbe riscoperta e che annovera veri e propri gioielli come Penny Whirton e sua madre, Il pinguino senza frack, Tobby in prigione, risente molto dell'influsso della tradizione anglosassone. Ora è possibile rileggerli, nell'ultima sezione di questa raccolta. E Fabrizio Frasnedi, oltre a rivalutare il primo romanzo, Essi pensano ad altro, ambientato "in una fantasmatica vecchia Bologna" rilegge così il senso ultimo di questi testi: "Era come se D'Arzo ci raccontasse, infine, che non si dà vera esperienza di sé se non ritornando bambini, e che solo i bambini sono davvero in grado di seguire la sua traccia".
Alberto Bertoni invece intuisce in Silvio D'Arzo la presenza di due matrici, una esistenzialista e l'altra religiosa e analizza i termini della ricerca religiosa darziana sottolineando l'influsso che poteva avere sulla sua formazione l'esperienza di Ferdinando Tartaglia che faceva conoscere Newman e Marcel. Così che il suo pensiero religioso si configura, per Bertoni,"votato a una problematicità psicologica e individuale talora ai confini dell'eresia". E conclude: "La verità di D'Arzo è consegnata al mistero dell'uomo, al silenzio che rende impenetrabile ed eroica la sua voce".
Fulvio Panzeri
Silvio D'Arzo, Opere, Mup
FIRENZE ANNI OTTANTA
Pier Vittorio Tondelli, nel suo consuntivo sugli anni Ottanta, indicava in Firenze la capitale morale di quel decennio, una città in cui si poteva sperimentare il nuovo e la creatività emergente a tutti i livelli, dalla musica alla moda, dal teatro alle nuove frontiere multimediali. E Tondelli non si era perso nessuno degli appuntamenti "cult" che hanno fatto storia in quegli anni nel capoluogo toscano, dai concerti dei gruppi emergenti agli spettacoli con le suggestioni e le atmosfere tecnologiche dei Krypton e dei Giovanotti Mondani Meccanici, dal clamore dei primi allestimenti dei Magazzini Criminali agli studi di Videomusic che frequentava molto volentieri.
E' stata quella una stagione tutta da rileggere, per capire anche questi nostri anni, con la sua voglia di innovazione e di postmoderno, una stagione in cui hanno mosso i primi passi Piero Pelù e i Litfiba, dove si sono consolidate esperienze musicali molto interessanti come quelle dei Violet Eves, con una straordinaria voce femminile, tutta anima e passione, giocata con grande senso del gusto, quella di Nicoletta Magalotti, che veniva chiamata "la Mina della Romagna".
Ora a quegli anni, Bruno Casini, un giornalista musicale che ha seguito da vicino tutte quelle esperienze, nella doppia veste di osservatore e protagonista, dedica un libro che è anche un ricchissimo album pieno di foto che documentano gli eventi o propongono i feticci di quel lungo "weekend postmoderno" consumato in riva all'Arno. Si intitola Frequenze fiorentine. Firenze anni '80 e presenta la voce di tutti i protagonisti di quella stagione, a partire da Federico Tiezzi dei "Magazzini" al regista Giancarlo Cauteruccio, da quell'acuto osservatore del costume che è Paolo Landi alla cantante e attrice Nicoletta Magalotti, da Stefano Tonchi, allora animatore con molti altri di una fanzine di lusso come "Westuff" fino al Tondelli delle cronache fiorentine. Il libro diventa così un viaggio tra discoteche e passerelle, 33 giri su vecchio vinile oggi introvabili, avventure segnate dal rock tecnologico, playlist e discografie. Documenta l'idea di un sogno che ha coinvolto l'intera città. Infatti Bruno Casini così ricorda: "Firenze sognava, sognava di diventare la piccola off London del Mediterraneo. Sognava di diventare la mecca del nightclubbing italiano, sognava di diventare il quartier generale del rock indipendente-made in Italy: per un attimo è diventata la città del rinascimento rock, per un attimo è diventata palcoscenico del nuovo rock, per un attimo fuggente ha imposto uno stile totale per le nuove generazioni alle soglie del duemila". E Nicoletta Magalotti ricorda i mille progetti di ognuno, il bisogno di dire basta al provincialismo e alla musica di consumo, ai linguaggi ammuffiti e alla televisione: "C'era la via di fuga, ed era codificata… dal contesto… Momento di grande energia, in molti stavamo vivendo un quotidiano che aveva già da sé superato lo steccato".
Fulvio Panzeri
Bruno Casini, Frequenze fiorentine. Firenze anni '80, Arcana, 2003
UN PEZZO DI MUSICA DAGLI ANNI OTTANTA
A Torino, all'inizio degli anni Ottanta, c'è "un sedicenne tormentato, chiuso in una stanzetta con un basso in mano e un fazzoletto sugli occhi". Sta scoprendo un nuovo tipo di musica che lo affascina molto, una nuova frontiera al punk degli anni Settanta che stava lasciando spazio ad una maggiore consapevolezza della realtà. Infatti le radio trasmettono le canzoni dei gruppi americani più radicali come Germs, X, Dead Kennedys. "Erano i primi esempi di hard core punk: un nuovo sottogenere musicale che mischiava l'immediatezza del rock'n'roll, rapidità di esecuzione mai sentita prima e liriche abrasive nei confronti della società, della politica e del potere dei media". Niente a che vedere con il nichilismo che aveva caratterizzato la precedente stagione del punk, anzi lo straight edge, filosofia antidroghe importata dagli USA, è il loro stile di vita. Quel sedicenne tormentato si chiama Silvio Bernelli e nonostante "l'energia sprigionata dalla nuova musica" avesse convinto lui e i suoi più estrosi compagni di scuola a fondare un gruppo che voleva essere tosto come i Killing Joke e romantico come i Joy Division, non è diventato una rockstar.
Né lui, né i suoi amici hanno mai piazzato una canzone in testa alla hit parade, né si possono vantare di vivere in ville con la piscina a forma di chitarra. Sono stati solo i protagonisti di una stagione intensa, vissuta nel mondo dell'underground, un territorio di locali occupato, abitato da ribelli anticonformisti. Non volevano diventare né ricchi, né famosi e pensavano "che la musica fosse solo un mezzo per esprimersi e cementare l'amicizia che li legava". Così questi musicisti che avevano formato gruppi quali "Declino", "Negazione" e "Indigesti" erano conosciuti come "i ragazzi del Mucchio".
E ora la loro storia, visto che la stagione per tutti si è chiusa e oggi si trovano a fare mestieri molto diversi e a condurre vite quasi agli antipodi fra loro, è diventata un romanzo, raccontata da uno di loro, Silvio Bernelli appunto, che, con uno stile scabro, quanto mai efficace, ci racconta un'epica, quell'insieme di band, relazioni, ambienti e persone "che disegna i confini di un movimento giovanile". E' proprio lo scrittore Giulio Mozzi ad ospitare questo testo nella collana "Indicativo presente" che dirige per Sironi editore. Il titolo è I ragazzi del Mucchio e si presenta come un "on the road" dagli scantinati di Torino all'Europa che ama la musica indipendente e poi in tourneè in America. E con loro, "un pugno di inguaribili outsiders", che firmano i dischi insieme, legati da un forte senso dell'amicizia si muove, al seguito delle band, il mondo giovanile degli anni Ottanta: un popolo di roadies, promoter, fan e sostenitori. Un libro che sarebbe piaciuto molto a Tondelli, soprattutto alla luce del consuntivo di Bernelli, il quale sostiene che le esperienze del Mucchio gli "abbiano donato, tra le altre cose, anche uno scarto di sensibilità, un moltiplicatore d'emozioni. Qualcosa che mi rende più triste quando sono triste e più felice quando sono felice".
Fulvio Panzeri
Silvio Bernelli, I ragazzi del mucchio, Sironi editore, 2003
TUTTE LE CANZONI DI NICK CAVE
Pier Vittorio Tondelli lo aveva celebrato come uno dei massimi poeti del rock, quando scriveva: "I poeti ufficiali si nascondono dietro le loro scrivanie e i loro libri. Hai la sensazione che oltre la capacità combinatoria, oltre la perfezione formale, non esista un'anima. Nei poeti rock, più o meno maledetti che siano, questa anima è eccentricamente viva e pulsante. E non solo nei grandi artisti dei decenni scorsi. Ma anche nell'oggi. E' il caso di Nick Cave". Un nome di culto per la musica punk, un vero artista maledetto che insegue l'inferno e il nulla, nella speranza di una redenzione, quasi gridando a Dio il suo bisogno di salvezza. Tra i suoi punti di riferimento ci sono grandi scrittori come William Faulkner e Flannery O'Connor, che non hanno mai smesso di raccontare la dura lotta dell'uomo in un'ottica biblica, trasformando la desolazione dell'America sudista in una metafora della terra promessa.
E la Bibbia è anche uno dei punti di riferimento di Nick Cave: "Intorno ai venti anni, cominciai a leggere la Bibbia, e trovai una infinita fonte di ispirazione nella brutale prosa del Vecchio Testamento, nella sensazione provocata dalle sue parole e dal suo immaginario, specialmente nell'apprezzabile serie di Canzoni d'Amore-poesie note come Salmi". E' un ricordo che emerge nel testo di una conferenza sul tema della "Vita segreta delle Canzoni d'Amore", tenuta dall'artista australiano a Londra, nel 1999 e pubblicata come introduzione a Tutte le canzoni 1978 -2001, tradotte da Michele Monina e pubblicate da Mondadori. Non è una semplice conferenza quella tenuta da Nick Cave, ma anche un'appassionata confessione sul suo fare musica, sulla necessità di scrivere canzoni, sul suo rapporto con Dio e con il religioso. La necessità di scrivere canzoni, di iniziare ad articolare le parole nasce dalla perdita del padre: "L'attualizzazione di Dio attraverso il mezzo della Canzone d'Amore rimane la mia prima motivazione come artista. Io ho trovato questo linguaggio che è diventato un toccasana per le ferite provocatemi dalla morte di mio padre. Il linguaggio è diventato un balsamo curativo".
Ha un'idea molto chiara su come deve essere una Canzone d'Amore Nick Cave, segnato nella sua musica dalla lezione di Leonard Cohen. La riferisce ad una definizione del grande Federico Garcia Lorca, vale a dire a quella forma di tristezza, che rende la forza misteriosa che non si riesce a esprimere, chiamata "duende". E dice: "Tutte le Canzoni d'Amore devono contenere "duende" perché la Canzone d'Amore non è mai semplicemente felice. Deve innanzitutto abbracciare il potenziale per il dolore". Nick Cave, nel tempo, ha scritto circa duecento canzoni che per la maggior parte affondano le radici in esperienze personali dirette. Quelle che ritiene la vera espressione della Canzone d'Amore le intuisce come "dei salvagenti lanciati dalle galassie a un uomo che sta affogando". E si definisce "un acchiappa-anime per conto di Dio". E dice: "Eccomi che soffio vita nei corpi e li lascio svolazzare verso le stelle e la cura di Dio".
Fulvio Panzeri
Nick Cave, Tutte le canzoni 1978 -2001, Mondadori, 2003
I ROMANZI E LA POESIA DI LEONARD COHEN
Prima di essere un folk-singer di fama, il Leonard Cohen che aveva studiato la Torah con il nonno rabbino, era considerato una delle promesse della letteratura canadese, prima con la fama di poeta maledetto e poi con un romanzo d'esordio, Il gioco preferito, uscito nel 1963 e ora riproposto, dopo trent'anni di assenza dalle librerie italiane, da Fazi. Accolto in modo favorevole dalla critica, è oggi considerato uno tra i dieci migliori romanzi canadesi del ventesimo secolo. Sono ancora lontani gli anni del primo disco che esce nel 1968 e già raccoglie alcune ballate che fanno parte della storia della musica da Suzanne a Sister Of Mercy. E la musica Leonard Cohen se la trova direttamente sulla sua strada: "Con la vendita di un libro non mantieni la famiglia. Fare il musicista invece mi ha dato questa possibilità. Ho iniziato per caso. Era la metà degli anni sessanta. Stavo andando a Nashville e passando per New York mi sono imbattuto nella rinascita del folk. C'erano Dylan, Joan Baez".
Quando scrive quel primo romanzo non ha ancora trent'anni, la stessa del protagonista Lawrence Breavman. Forse sono possibili paralleli tra lo scrittore e il suo personaggio, ma non si può parlare di scrittura autobiografica. Lo afferma lo stesso Cohen: "Lawrence Breavman non sono io, ma abbiamo fatto un sacco di cose insieme. Solo che le nostre reazioni erano diverse, così siamo diventati uomini diversi". Il protagonista è il figlio unico di un'antica famiglia di ebrei canadesi, scrive poesie, ha una passione per l'ipnotismo. E racconta, sullo sfondo della Montreal del dopoguerra, un percorso di formazione, tra perdite e abbandoni, depressioni della madre e incontri con altri ragazzi, oltre alla scoperta della forza dell'amore. Poi lo scenario cambia e abbiamo i primi anni di vita a New York. E in una lettera così spiega cosa significa per lui quel libro d'esordio: "Il gioco preferito non è solo un libro sull'adolescenza, è un'allegoria per un corpo perduto, perfetto, pallido, impossibile, quello che sfugge quando diamo un bacio…".
C'è un grande interesse verso il Cohen più strettamente letterario, lo dimostrano le proposte di alcune piccole case editrici. Simone Barillari, che ha curato la nuova edizione de Il gioco preferito, traduce anche il secondo romanzo per Fandango, Beautiful Lovers, la storia di un uomo, solo e disperato, ossessionato dal ricordo della moglie che si è suicidata, che compie, quello che Cohen definisce "un viaggio sfrenato e inquietante nei paesaggi dell'anima".
E arrivano anche le sue poesie, in una scelta curata dallo scrittore Giancarlo De Cataldo, intitolata L'energia degli schiavi. Sono di grande interesse a partire dalla sezione che presenta una raccolta del 1964, che nasce dall'impatto con le pagine di Hannah Arendt sul processo Eichmann. Sostiene, a ragione De Cataldo: "Anche se il libro non parla soltanto dell'Olocausto, esso si può considerare come il contraltare poetico della "banalità del Male"."
Fulvio Panzeri
Leonard Cohen, Il gioco preferito, Fazi, 2003
Leonard Cohen, Beautiful Lovers, Fandango, 2003
Leonard Cohen, L'energia degli schiavi, Minimum Fax, 2003
I VIAGGI DI JACK KEROUAC
Pier Vittorio Tondelli sarebbe stato senz'altro affascinato dai molti libri sul tema del viaggio che sono apparsi in libreria nel 2002. E avrebbe senz'altro divorato il piccolo libro di uno dei suoi autori preferiti, Jack Kerouac.
Sulla necessità di riscoprire ciò che è "vicino" insiste Alain De Botton, scrittore culto degli anni Novanta e autore de L'arte del viaggiare, pubblicato da Guanda, una riflessione corredata da un ottimo apparato di fotografie e illustrazioni sui temi salienti quali i mezzi di trasporto, le motivazioni al viaggio, la scoperta dell'arte e il ritorno. Dice infatti: "Andare sempre a scegliere mete esotiche, dimostra una mancanza d'immaginazione. La vera sfida del viaggiatore di oggi è andare non troppo lontano da casa e scoprire che cosa ci sia di bello e affascinante nei luoghi che frequentiamo sempre ma che non abbiamo mai il tempo o la voglia di conoscere meglio".
A dire la sua, sui viaggi, c'è anche uno scrittore che la strada la conosceva bene, Jack Kerouac, che ci racconta in L'ultimo vagabondo americano viaggi negli Stati Uniti, in Messico e in Marocco, a Parigi e a Londra, con la loro varietà di gente e di luoghi. Scrive: "Ho risparmiato al centesimo per poi sperperare tutto in un glorioso grande viaggio in Europa o in qualsiasi altro posto, sentendomi leggero e felice".
Stessa conclusione cui giunge De Botton quando sottolinea che "l'arte di viaggiare pone una serie di interrogativi il cui studio potrebbe modestamente contribuire alla comprensione di ciò che i filosofi greci indicavano con la bella espressione eudaimonia, ovvero felicità".
Fulvio Panzeri
Jack Kerouac, L'ultimo vagabondo americano, Oscar Mondadori (2002)
RITORNA SILVIO D'ARZO, UNO DEGLI AUTORI PIU' AMATI DA TONDELLI
Tra Reggio Emilia e l'Appennino Emiliano si situa una delle esperienze più singolari del nostro Novecento letterario cosiddetto "minore", quella di Ezio Comparoni (alias Silvio D'Arzo) morto giovanissimo a trentadue anni e autore di racconti per ragazzi, romanzi giovanili, saggi sulla letteratura inglese e di un piccolo classico, un romanzo breve come Casa d'altri. D'Arzo era uno degli autori più amati da Pier Vittorio Tondelli che ha contribuito in modo essenziale alla sua riscoperta.
A cinquant'anni dalla morte alcuni convegni hanno rivisitato criticamente quell'esperienza, importante anche per molti narratori di oggi da Claudio Piersanti ad Eraldo Affinati. E' uscita anche l'edizione critico-genetica di Casa d'altri, curata da un giovane studioso reggiano, Stefano Costanzi, che con questo lavoro filologico si pone tra i più competenti studiosi di D'Arzo oggi.
Costanzi racconta la storia del testo e delle sue redazioni, dopo aver studiato con attenzione le varie stesure del testo darziano, compresi i dattiloscritti originali e elabora una propria tesi: la versione che noi leggiamo oggi, ritenuta definitiva dal curatore dell'opera completa di D'Arzo, è arbitraria e suffragata, più che da motivi critici, da considerazioni "idelogiche" relative al testo. E ne propone una diversa versione, corrispondente a quella pubblicata nel 1953, nella prestigiosa "Biblioteca di Paragone", la rivista diretta da Anna Banti e Roberto Longhi. Possiamo quindi rileggere questo piccolo classico che, in tempi di neorealismo imperante, poneva l'attenzione sul dramma esistenziale dell'uomo, sull'inquietudine cosmica, attraverso le figure di un prete e di una donna, Zelinda, sola con le sue capre, in uno sperduto paesino dell'Appennino. La donna, corroborata dal peso della sua solitudine, svela al parroco il suo segreto e gli chiede una dispensa, quella che le permetta di porre fine alla sua misera vita. Secondo Alberto Bertoni, che firma l'introduzione, il racconto pone "il problema dell'attualità, della necessità e della giustizia di Dio tra uomini già di loro condannati a una vita da capre".
Fulvio Panzeri
Silvio d'Arzo, Casa d'altri, Nino Aragno editore (2002)
ANCHE UN RACCONTO DI TONDELLI PER UN'ANTOLOGIA SUL NATALE
Il Natale è una festa che i narratori non hanno mai ignorato: lo dimostra questa bella antologia, pubblicata da Marcos y Marcos che dedica il lavoro solitario di chi scrive alla figura del quarto re magio che, secondo la tradizione e la leggenda a lui riferita, si ferma lungo il cammino e non riesce a raggiungere Betlemme. In lui si riflettono i caratteri del sognatore, del profeta e di colui che sta dalla parte dei più deboli, attraverso la sua capacità di donare, ma soprattutto di mettersi in ascolto. La sua figura è un po' la metafora dello scrittore che si avvicina al Natale e cerca di comprenderlo attraverso le storie.
Questa antologia ne raccoglie molte, assai diverse tra loro, per ambientazione storica e per provenienza geografica, così da restituirci un Natale diverso in ogni parte del mondo, dal Medio Oriente del 1947, in Libia, mentre lì vicino si stanno costituendo i due piccoli stati di Israele e del Libano, raccontato da Luciano Bianciardi all'Italia delle case popolari e del disadattamento delle periferie urbane, proposto da un giovane autore, all'esordio, Cristiano Cavina, che farà senz'altro parlare di sé, dalla Berlino "on the road", tra gelo e necessità di dare un senso alla propria solitudine, riprese nelle brevi istantanee narrative di Tondelli, fino all'indignazione per il massacro delle capre che si compie alle vigilia di Natale, in un paese africano, che emerge dal racconto di Dambudzo Marechera, poeta, narratore e drammaturgo dello Zimbawe, nonché l'Irlanda e le sue tensioni sociali e ideologiche, registrate con maestria, dal grande William Trevor.
E' una specie di viaggio immaginario quello composto dall'antologia che presenta anche molti testi "classici", che nell'accostamento con testimonianze riferite più direttamente alla contemporaneità, acquistano un nuovo valore. Ci riferiamo alle indagini nello spazio di Arthur C. Clarke, l'autore di 2001 odissea nello spazio, ai magici racconti dell'inglese O. Henry, con i suoi doni impossibili, all'uovo caldo di Guy de Maupassant, alla natività vista da Pasolini nel Vangelo secondo Matteo, di cui qui viene presentato un estratto dalla sceneggiatura e, infine, all'incantato e terribile Cristallo di rocca, uno dei capisaldi della letteratura dell'Ottocento, firmato Adalbert Stiflter, la storia di due bambini, in un paesino di montagna austriaco, che dopo essere stati dai nonni, sono colti da una improvvisa bufera di neve e si perdono nell'immensità del bianco che tutto copre e nasconde la strada, lasciando i due piccoli intirizziti e impauriti in cerca di un rifugio.
Fulvio Panzeri
AA.VV., Il quarto re magio. Storie di Natale, Marcos y Marcos (2002)
Sei qui: HOME | |
|
|
|